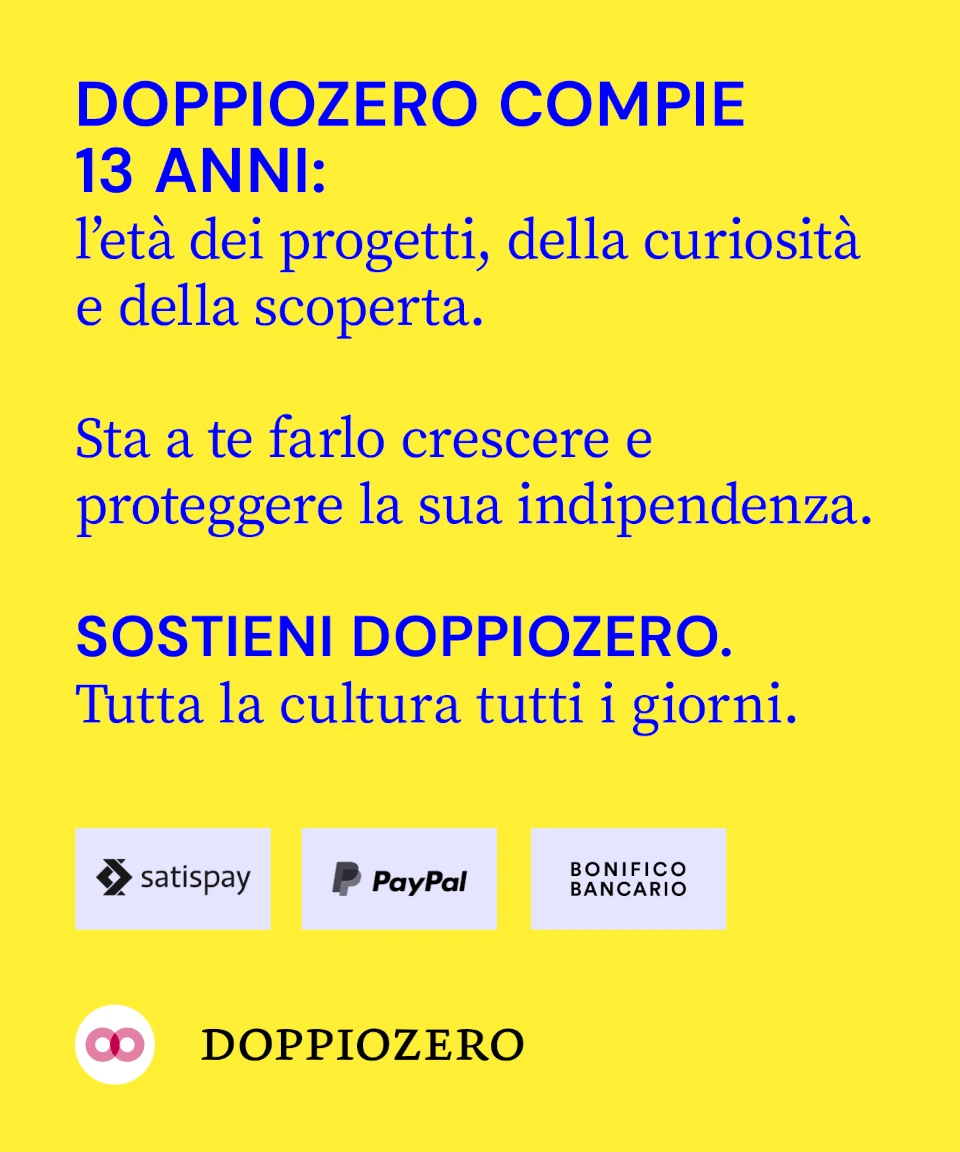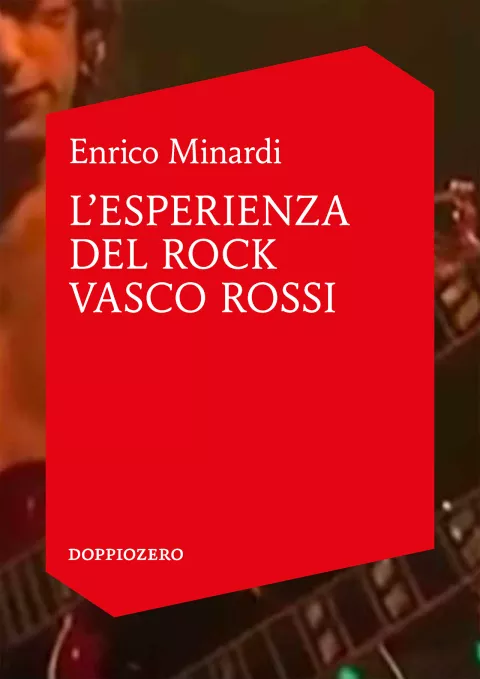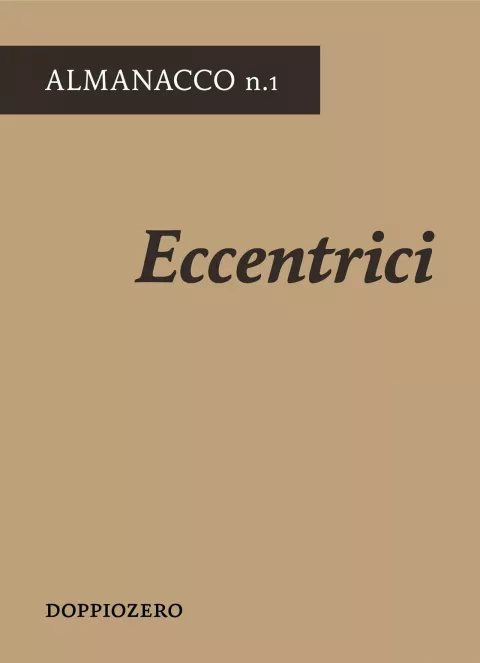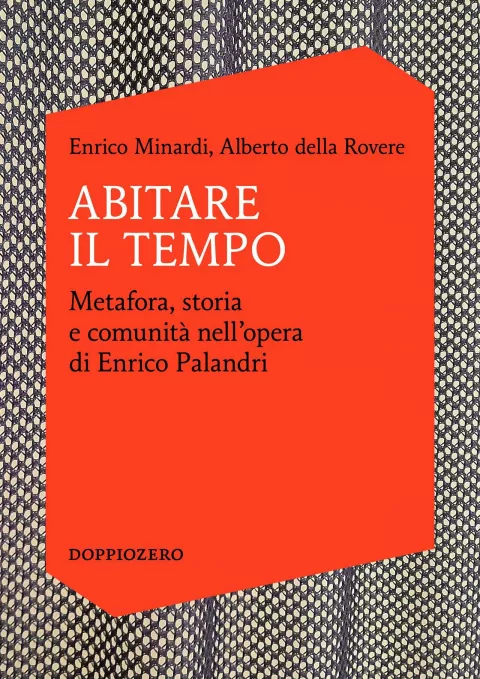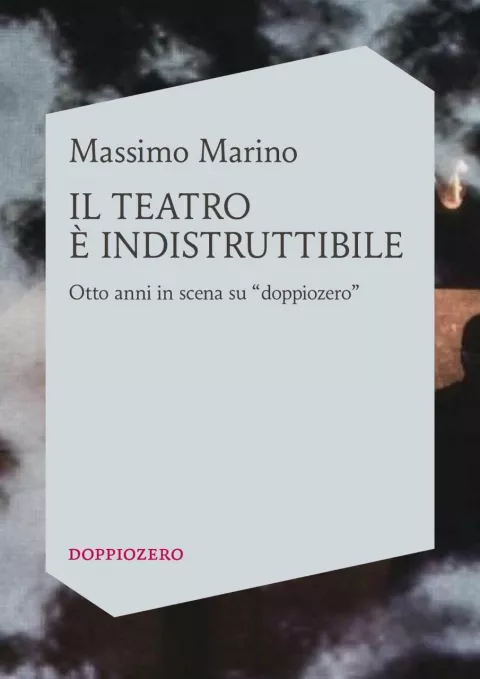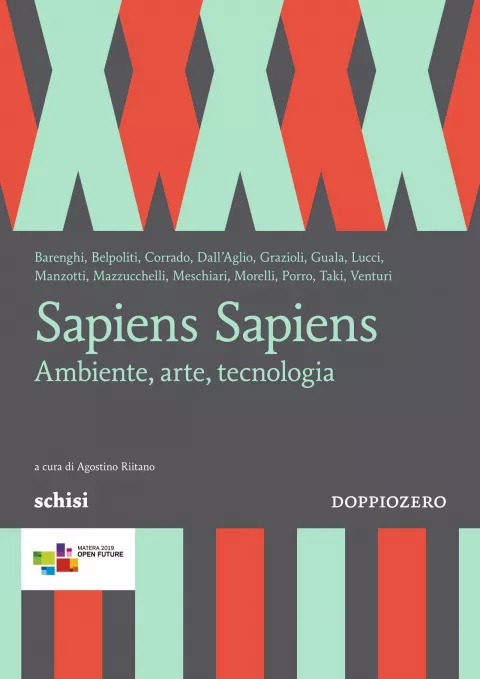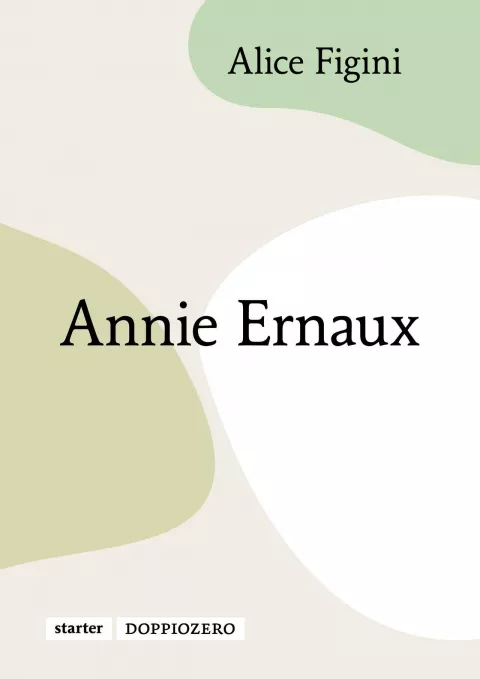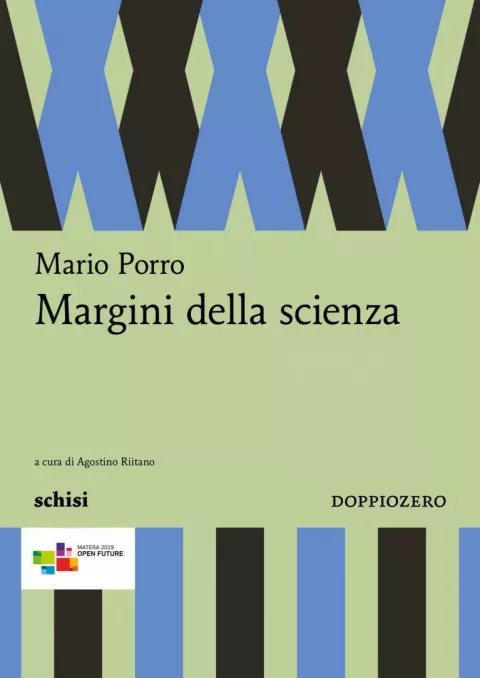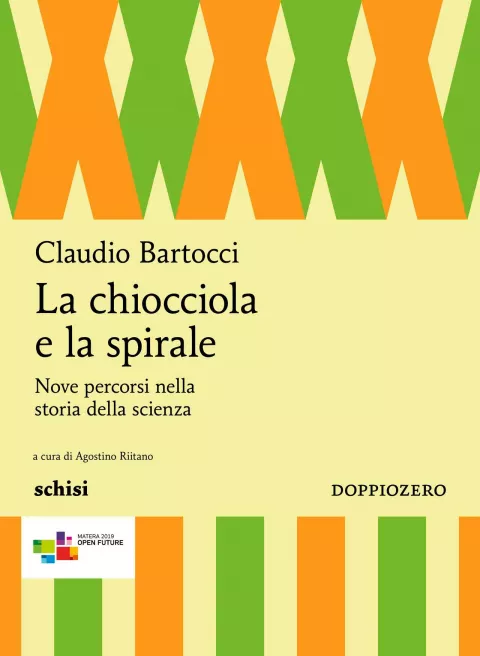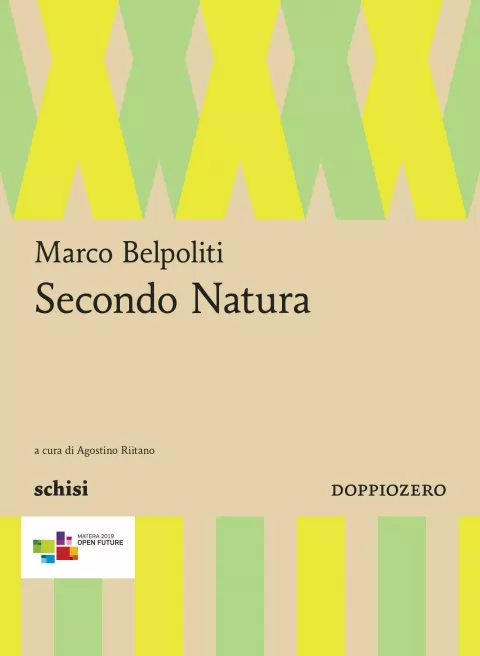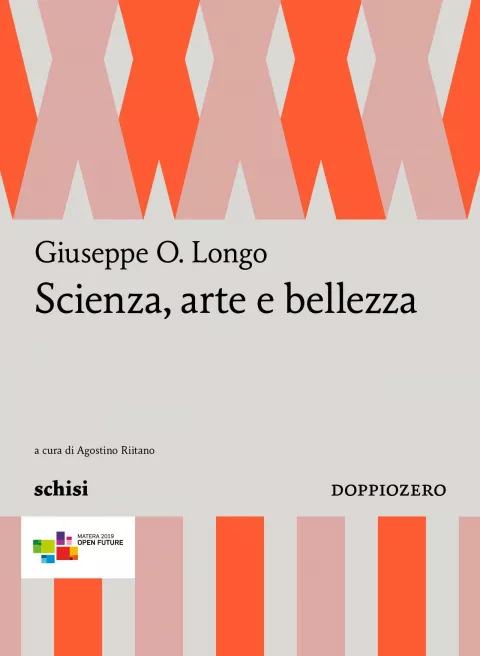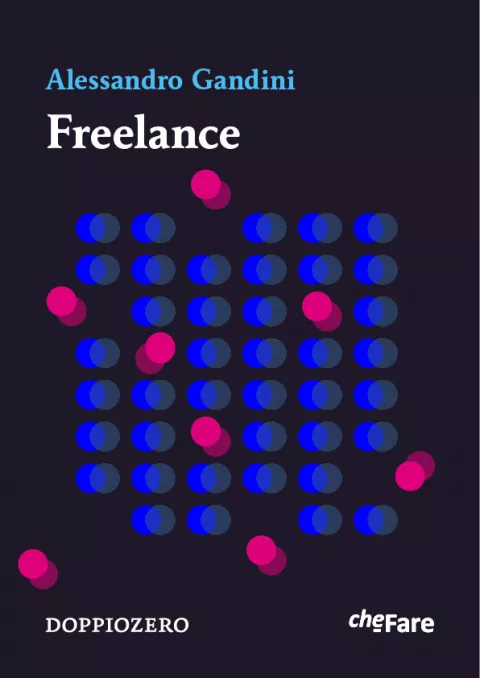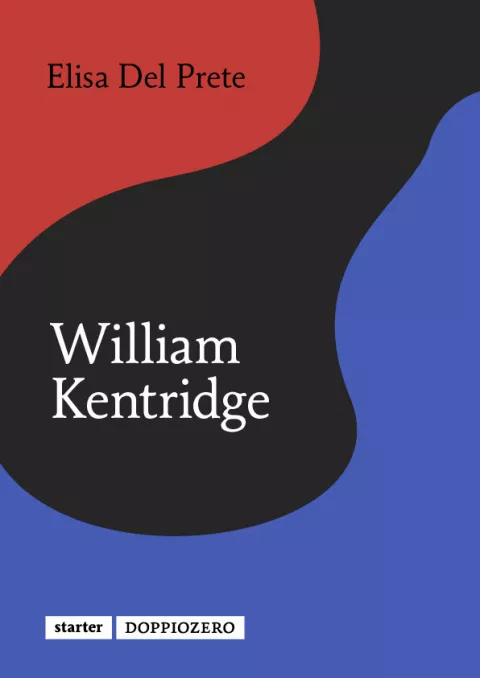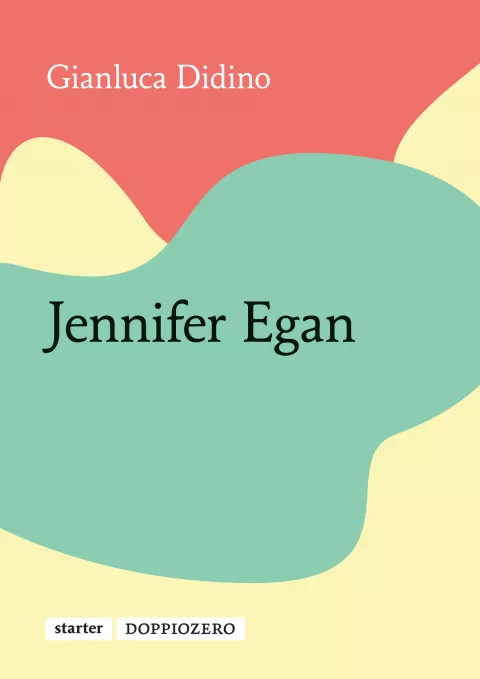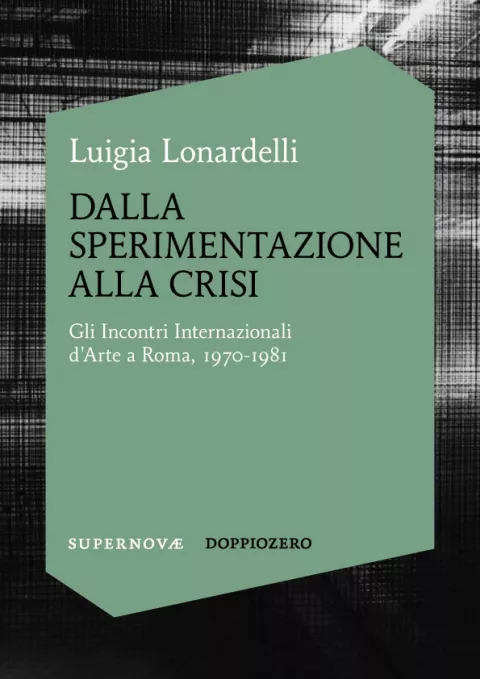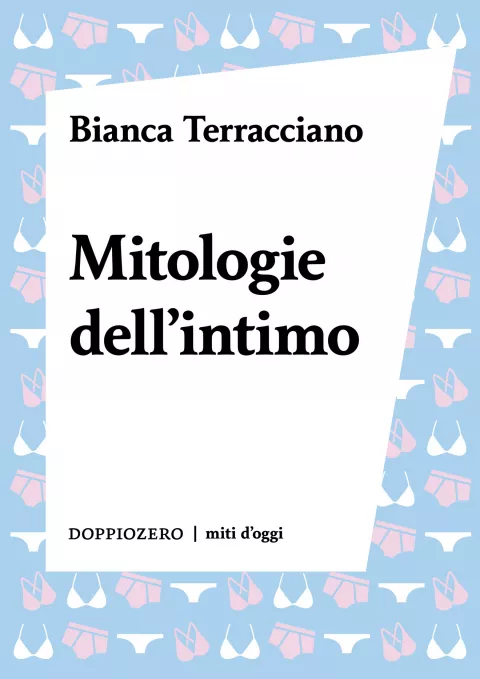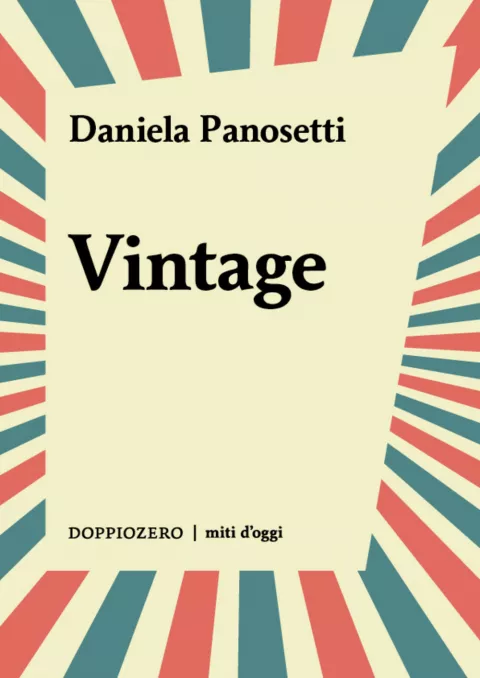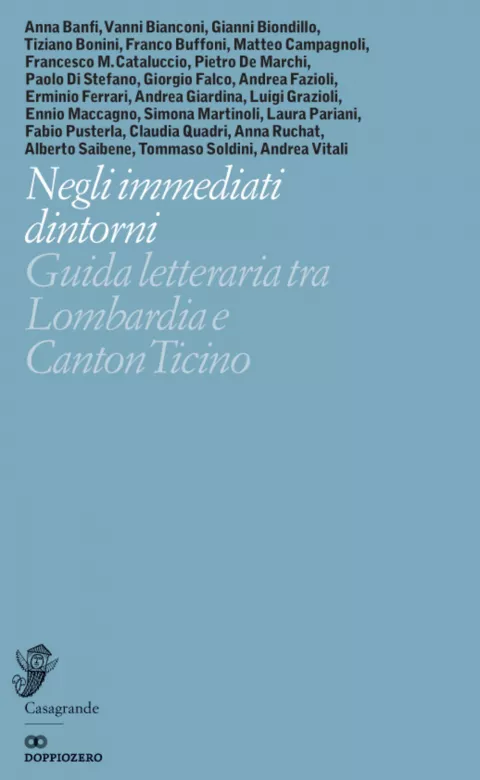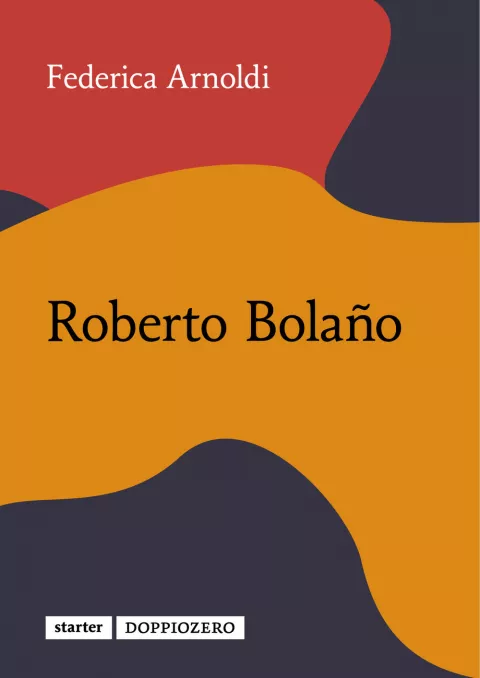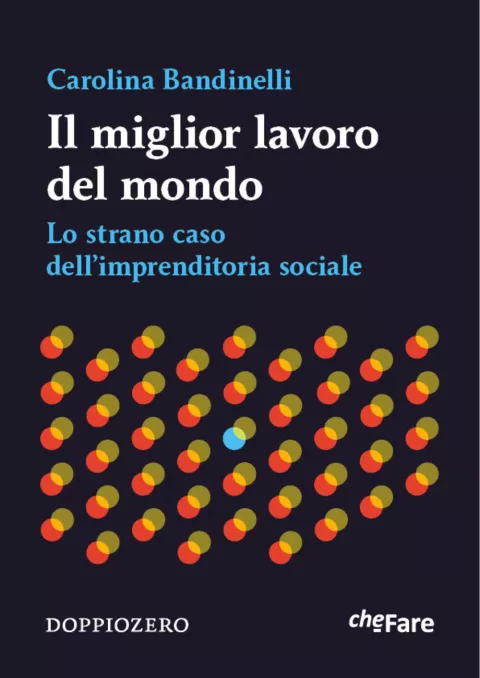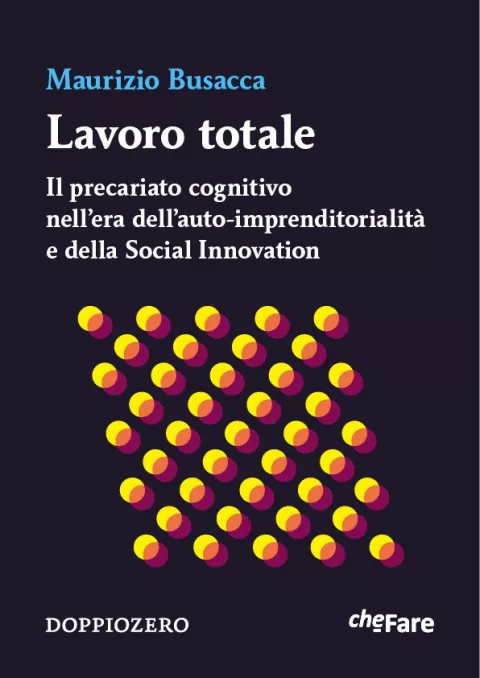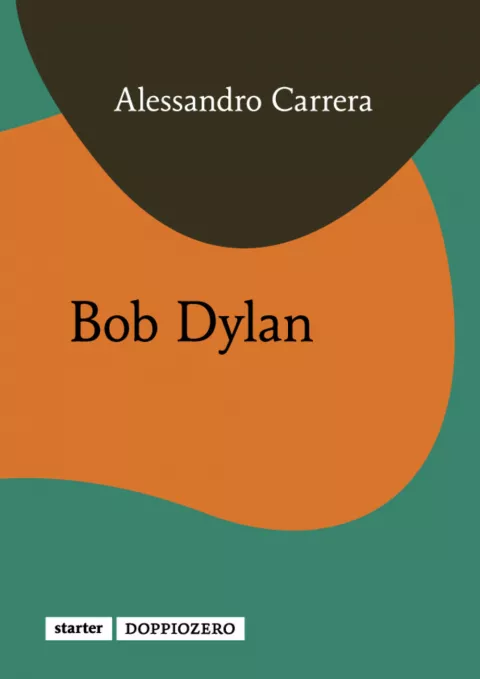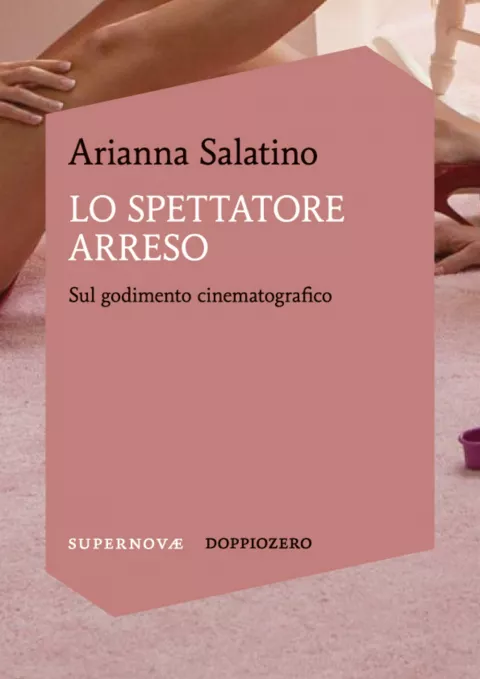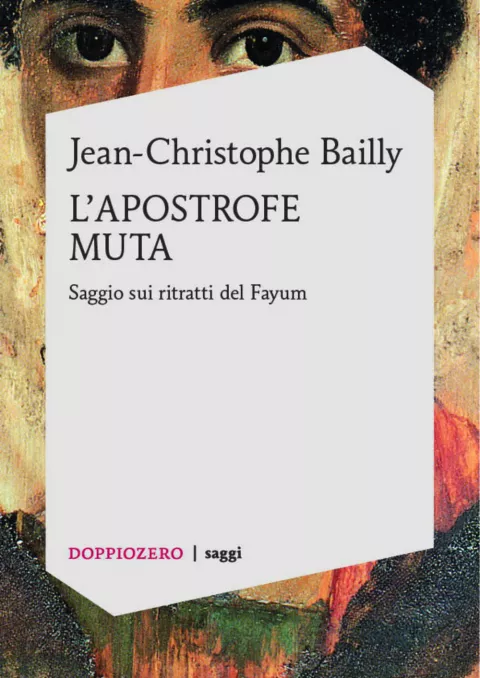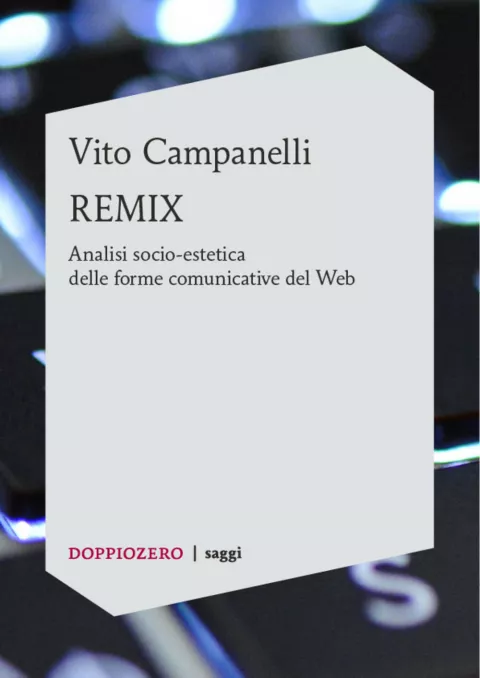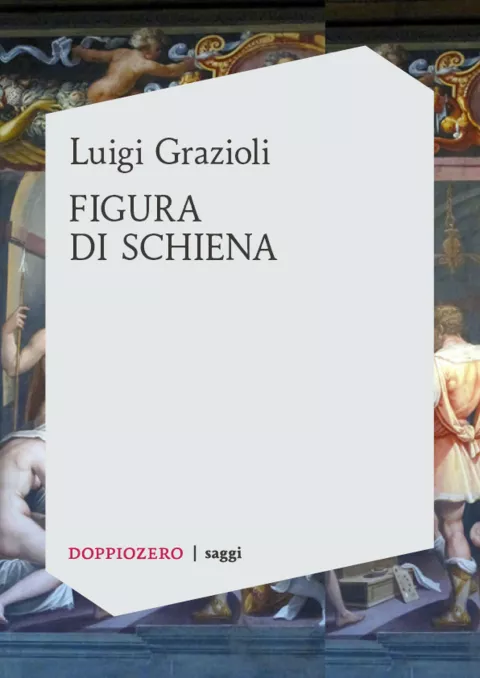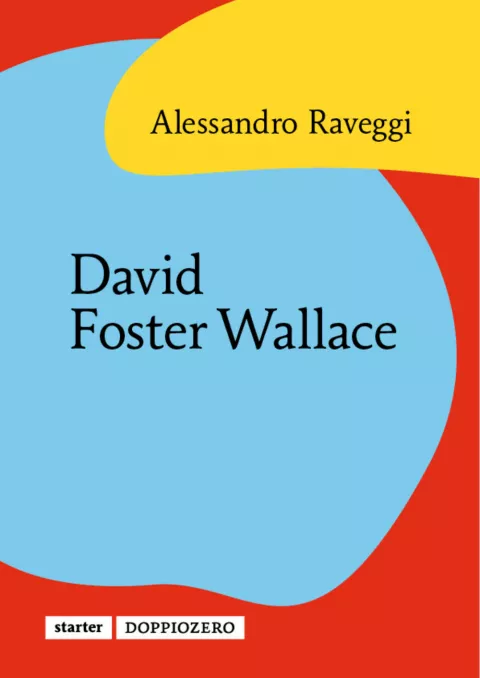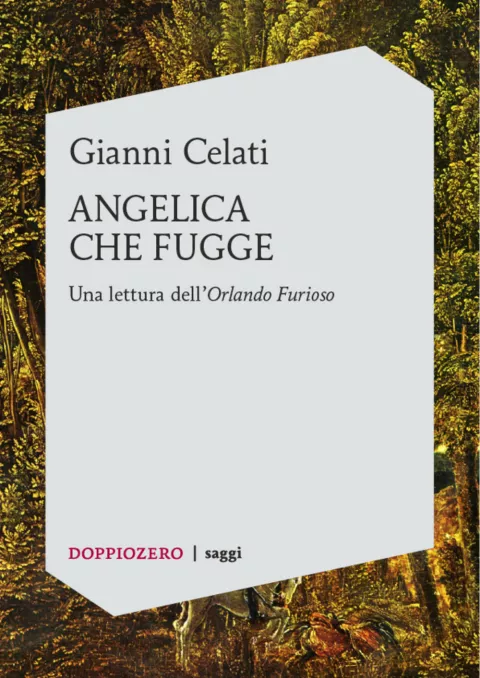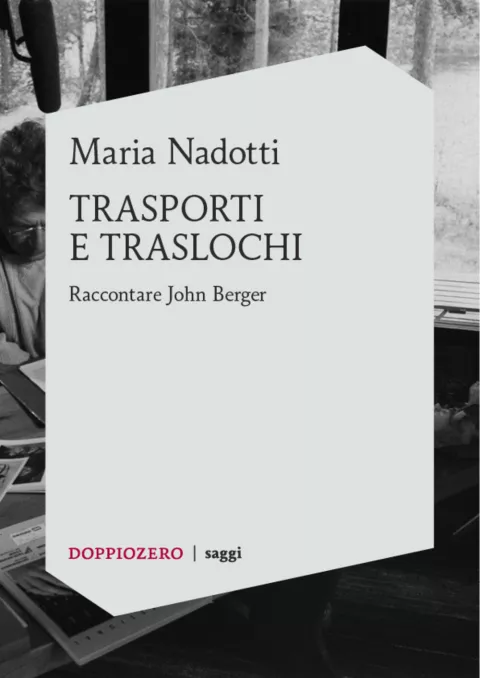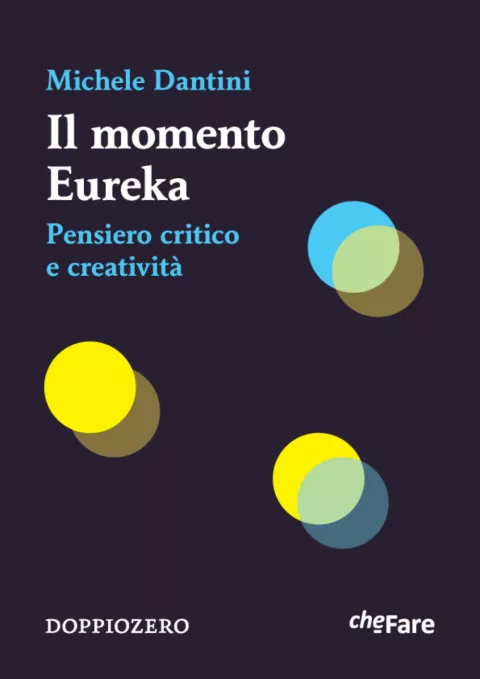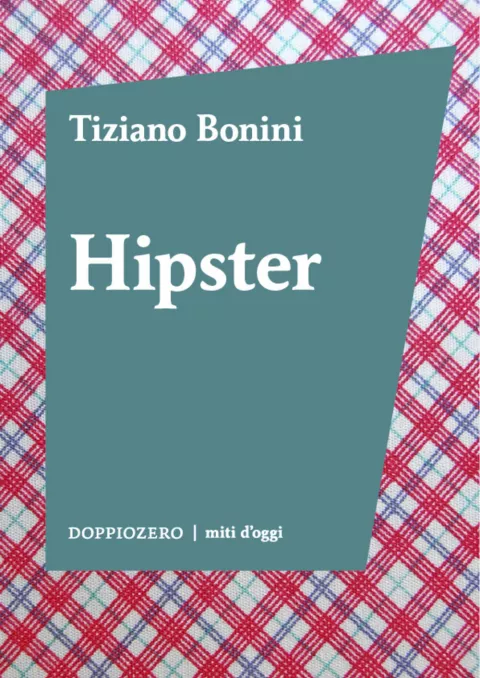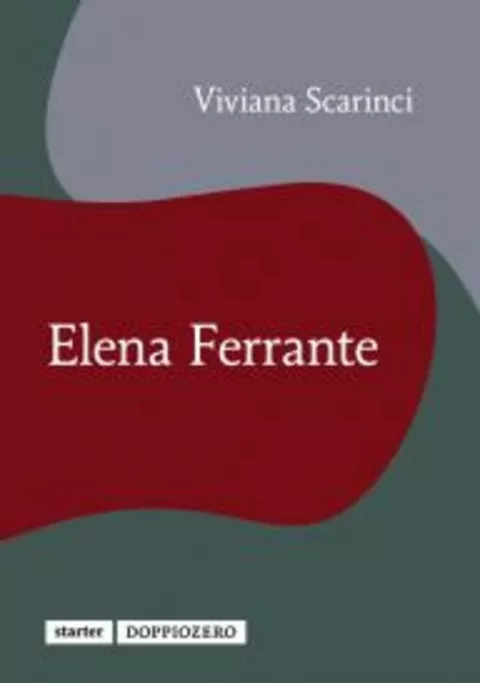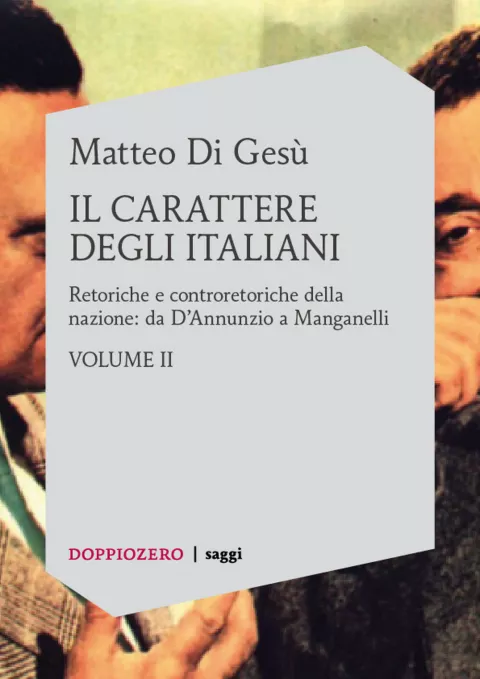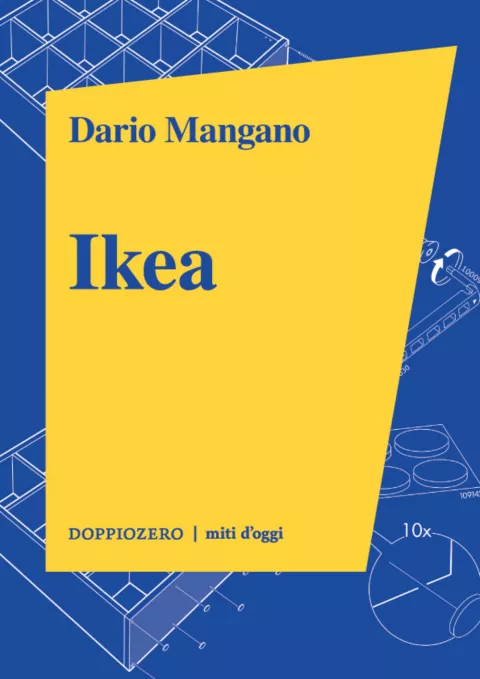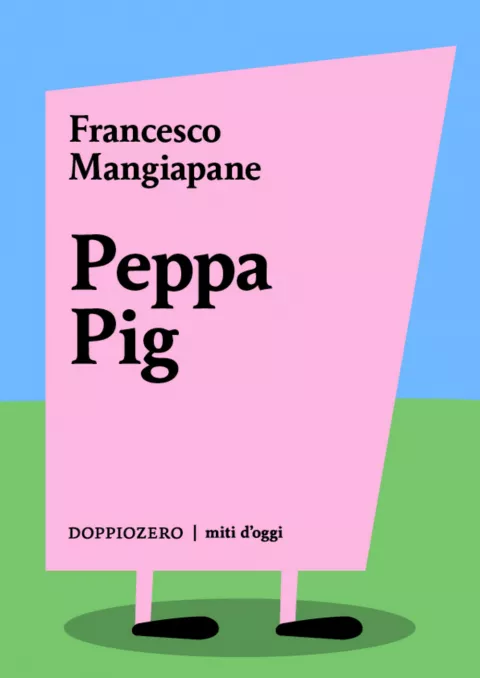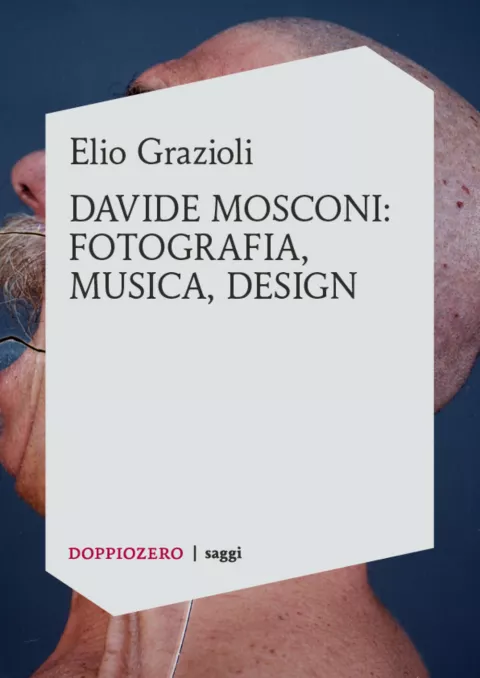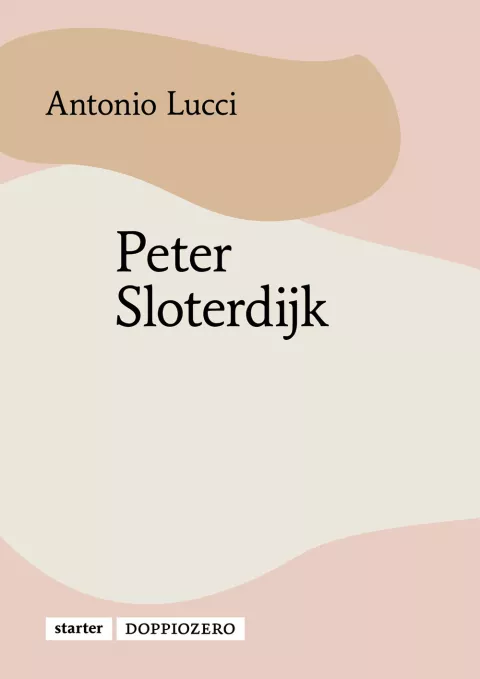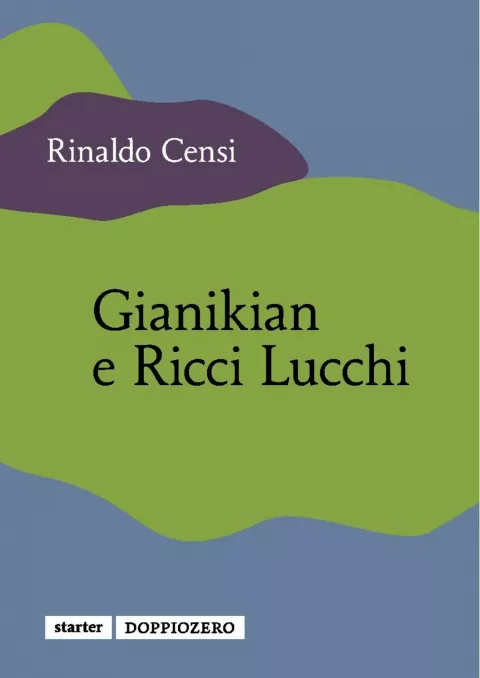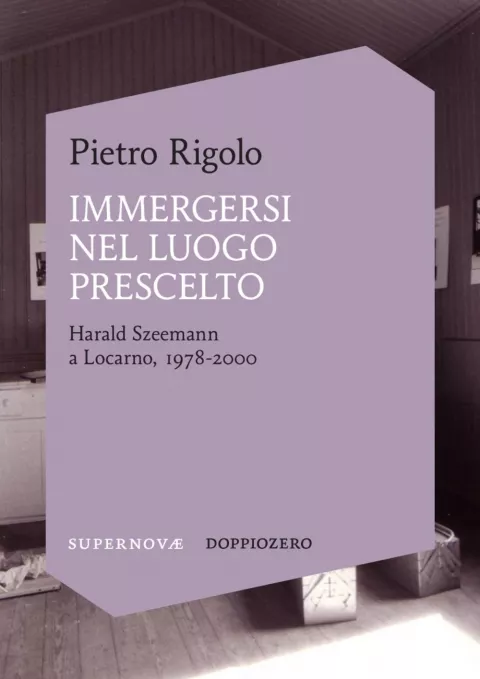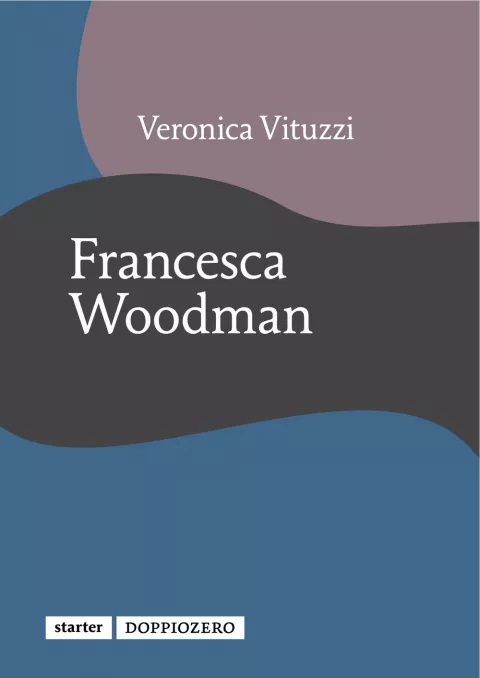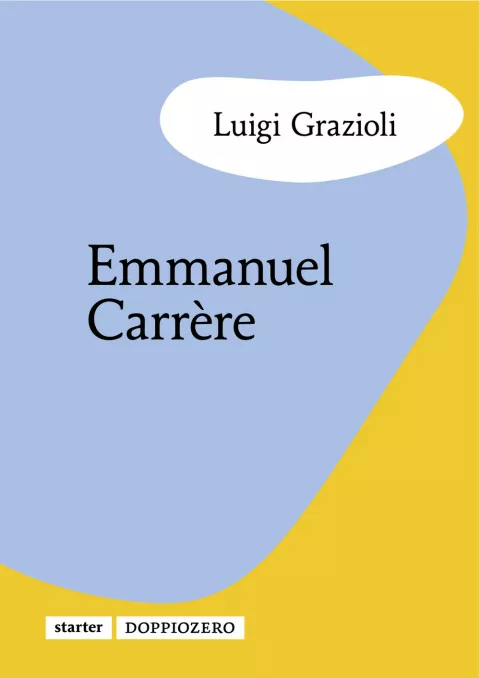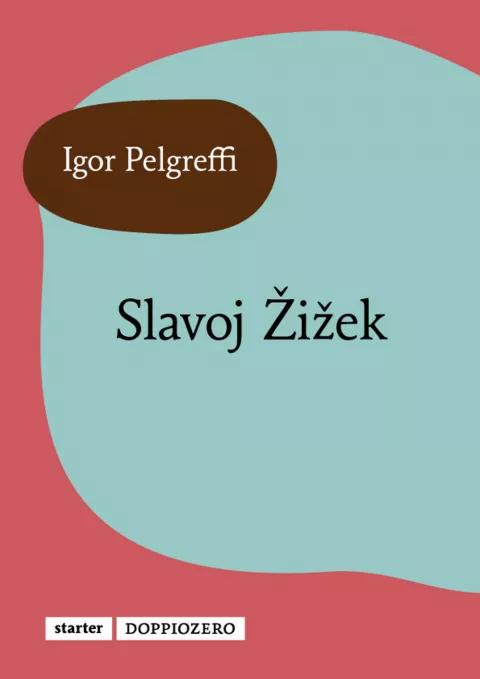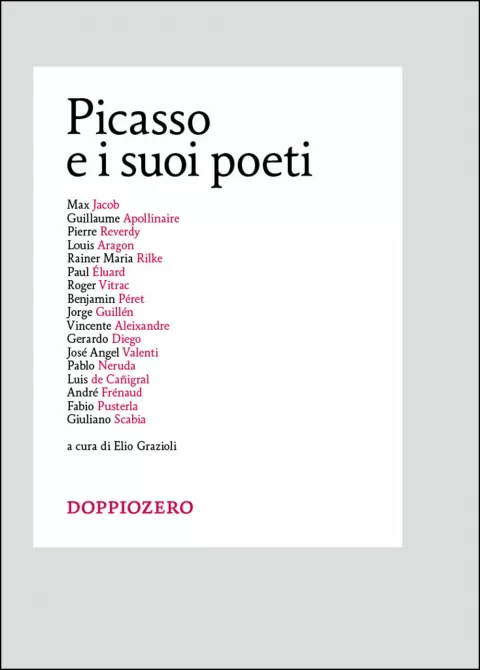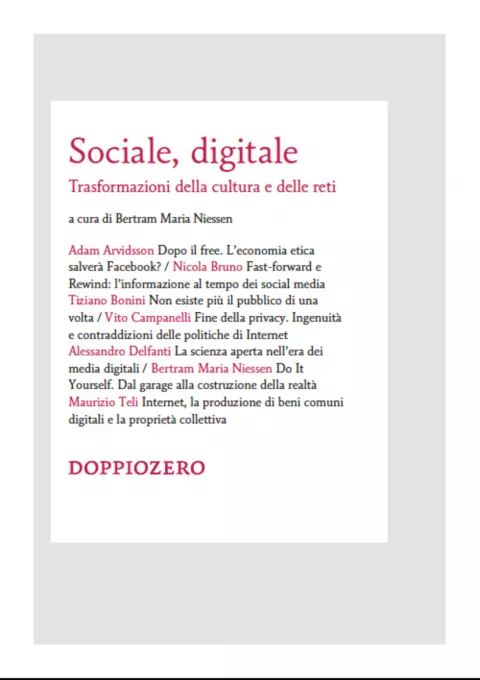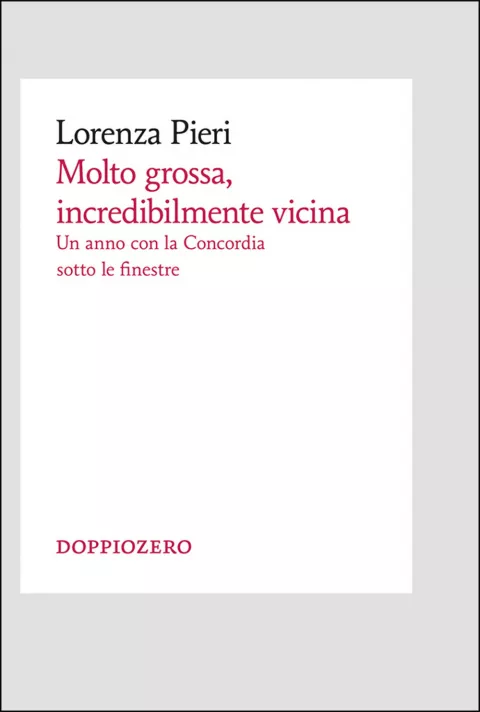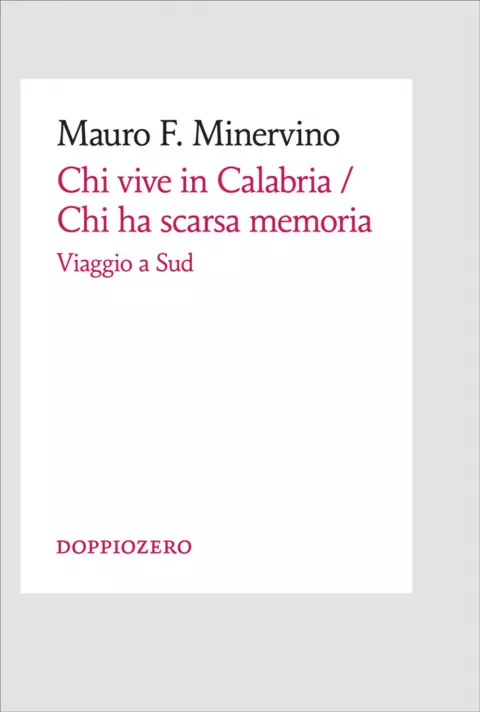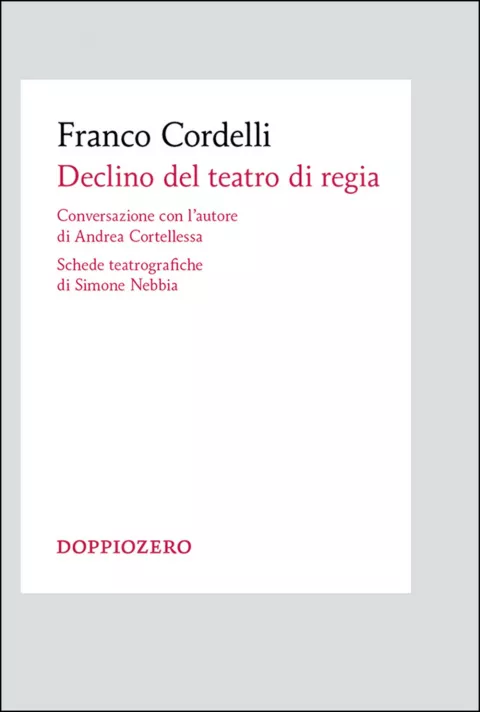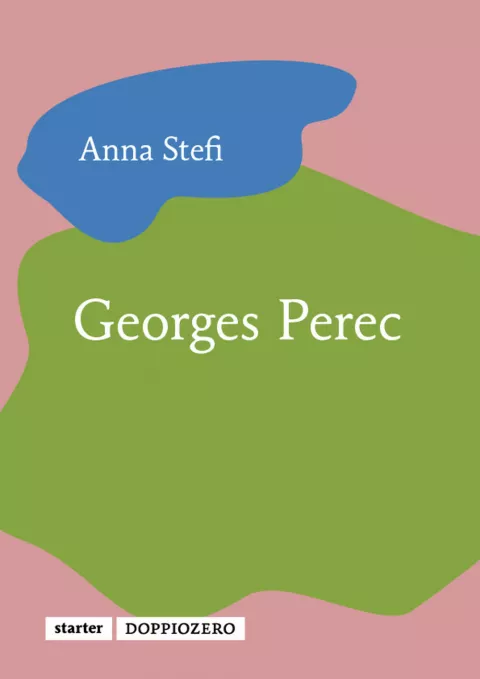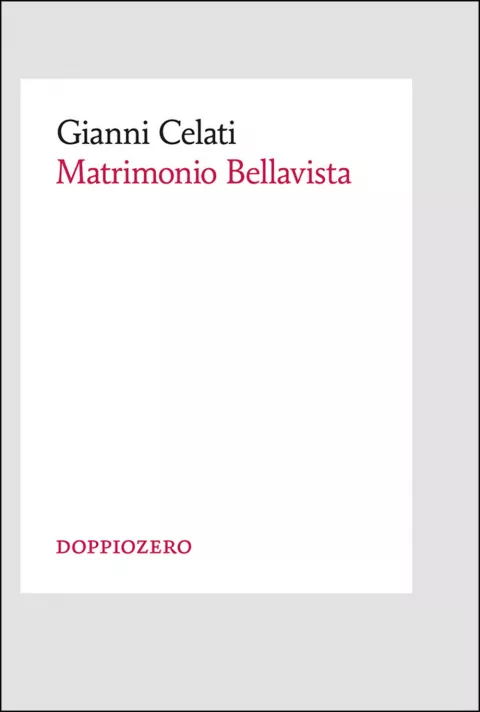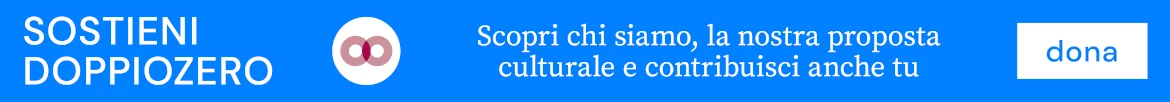Articoli del giorno
Categorie
Democrazia in crisi
Uno speciale sul tema della crisi della democrazia, a cura della redazione di doppiozero, a partire da una frase di Carlo Galli: "La crisi della democrazia in Occidente è dovuta a dinamiche economiche che acuiscono le diseguaglianze sociali, al crescente dominio della tecnica che soffoca il cittadino in una rete di crescenti adempimenti e controlli, al proliferare delle emergenze interne ed internazionali che generano ansie e aggressività nella società; ma è dovuta anche al fatto che il motore politico della democrazia fatica a intervenire per normare le nuove esigenze individuali e le nuove sensibilità a cui dare risposte in linea con i principi costituzionali. Questa latitanza della politica è un potente fattore di delegittimazione delle procedure democratiche, e dello Stato al cui potere legislativo spetterebbe il compito di agire".
Italia: che fare?
Italia che fare? In attesa delle elezioni del 25 settembre abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di immaginare cosa inserire nell'agenda di governo se toccasse a loro dare suggerimenti ai ministri che verranno: idee, progetti, azioni concrete.