Donatella Di Cesare / La rivolta è ovunque
Dentro il paesaggio di città svuotate dall’emergenza, in quell’esperienza che allora si chiamava ancora “quarantena”, parola presto sostituita dal termine vagamente carcerario di lockdown, diventato imperante, irrompeva tutt’altra immagine: quella di un uomo inchiodato sull’asfalto dal ginocchio di un poliziotto che stava procedendo al suo arresto. A quell’immagine muta si è subito aggiunta una voce, la voce dell’uomo steso a terra, che domandava di poter respirare. L’uomo era nero, l’agente di polizia bianco, il luogo Minneapolis. Da lì a poco I can’t breathe sarebbe diventato il grido di protesta non solo della comunità afro-americana, soggetta a un costante razzismo da parte delle forze dell’ordine, ma di tutti coloro che hanno preso parte alle manifestazioni in strada del movimento Black Lives Matter e alla successiva rivolta urbana che si è poi diffusa nelle maggiori città degli USA.
La posta in gioco della rivolta riguardava là qualcosa di invisibile ma essenziale, come l’aria stessa. Qui è il punto in cui la sua urgenza politica si salda con il concetto di vita e I can’t breathe diventa l’urlo di guerra di tutti coloro che chiedono a gran voce il rispetto dei propri diritti elementari, senza i quali la vita stessa viene distrutta. In un certo senso tutto nasce dalla constatazione che in determinate situazioni di violenza diffusa da parte delle istituzioni è negato anche il più elementare dei diritti.
Come il respiro, anche la rivolta è invisibile, se non negli istanti in cui si concretizza nelle forme di lotta, nella presenza nelle strade. Invisibile, ma onnipresente, questi caratteri la rivolta sembra condividerli anche con la propagazione del virus, a cui questi ultimi mesi ci hanno abituato. Poche altre cose sembrano oggi più inafferrabili. Liquido e onnipresente, anche l’evento della rivolta non conosce confini. Irrompe ovunque in forma di disobbedienze, di occupazioni, di proteste, di nuove pratiche politiche di comunità. L’irruzione è la sua forma.
Buenos Aires, Hong Kong, Rio de Janeiro, Beirut, Londra, Bangkok: il tragitto di riflessione che Donatella Di Cesare compie in Il tempo della rivolta accoglie la sfida di stare dietro questa lista virtualmente infinita di un fenomeno che pare moltiplicarsi ovunque senza pausa. La sua proliferazione è la forma politica emergente del mondo contemporaneo.
Sulla rivolta una tradizione angusta ma persistente ha preteso di far valere un pregiudizio in auge ancora oggi: la sua non sarebbe nulla più che un’esplosione di rabbia di corto respiro, l’esplosione di una negatività radicale, che mancherebbe di un carattere politico propriamente detto. Sarebbe dunque incapace di capitalizzare le sue conquiste e di dare loro un carattere stabile. Ogni rivolta si compie e si esaurisce – dice quel pregiudizio – nell’evocare i demoni notturni della città, scatenando il disordine, ma resterebbe invece inadeguata di progettare un avvenire. Parte di questo pregiudizio coriaceo deriva dal fatto che la rivolta rovescia la prospettiva abitale della politica: non programma la presa di nessun Palazzo d’inverno o di nessuna Casa Bianca, non si interessa della conquista del potere, ma unicamente di far emergere un’anarchia capace di consumare il progetto della sovranità a rappresentare e a ordinare tutto. Citando un grande intellettuale italiano com’è stato Furio Jesi, Di Cesare ci ricorda che “se la rivoluzione prepara il domani, la rivolta evoca il dopodomani. È dunque un istante di folgorante conoscenza, perché dischiude uno squarcio sul futuro. Di qui la sua inattualità”.
In questo senso, la rivolta rovescia il piano che abitualmente mette in prima posizione la sovranità e con essa il potere. Si distacca dalla narrazione dominante, anche in ambito rivoluzionario, quella progressista ed emancipatrice. Piuttosto bisognerà dire che apre alla necessità di un altro lessico a venire, a cui non siamo ancora abituati, ma la cui esigenza vive già dentro la nostra visione, spesso incapace di tradursi in pratiche politiche. In questo senso la rivolta è un lungo, reiterato momento di destituzione, che riguarda i soggetti stessi che si trovano immersi e coinvolti nella rivolta. La rivolta è trans per eccellenza: trans-femminista, transessuale, trans politica, transfuga. Agisce al di là dei vincoli o delle appartenenze “naturali”, le rimette in questione. È una sfida alle costrizioni identitarie o forse non le sfida nemmeno: le abbandona come vecchi orpelli di un mondo che resiste al proprio cadavere. Così, mentre nella concezione classica, la rivoluzione è considerata il prodotto di una ben determinata soggettività politica (per esempio, la classe lavoratrice), la rivolta segna invece un senso più ampio di partecipazione di soggettività differenti, fluide, di attori che restano per lo più anonimi e che anzi trovano nell’anonimato il modo stesso del loro operare. Se la cultura occidentale pensa la propria partecipazione alla dimensione politica in termini identitari, la rivolta li rimette radicalmente in gioco.
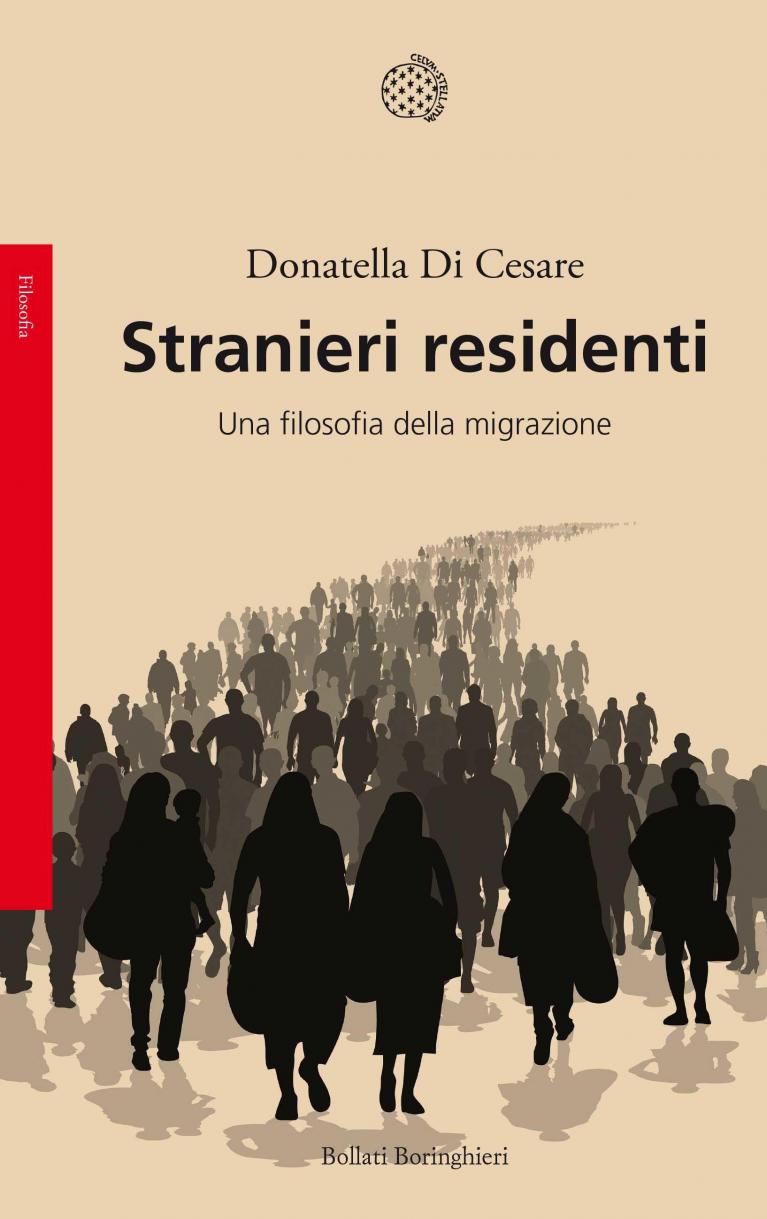
Così il ricorso alla maschera, all’incappucciamento, non è leggibile solo come esigenza strategica, ma soprattutto come richiesta di sbarazzarsi del proprio sé, di rigiocare il soggetto verso i suoi lati in ombra e verso un’esplorazione che resta tutta a venire. Così l’anonimato appartiene alla forma stessa della rivolta, come risultato di un’epoca in cui il dissenso è criminalizzato e represso. In cui il prezzo da pagare per dissentire finisce per essere inaccettabile per delle vite già abbandonate alla loro fragilità.
Rivendicare i luoghi nevralgici delle città, là dove batte il cuore della metropoli, significa denunciare che lo spazio pubblico è sempre più alienato dalle varie normative anti-terroristiche o dalle politiche di decoro ed è sempre più privatizzato dallo sfruttamento commerciale di vie e piazze. Rispetto alla militarizzazione dello spazio urbano occorre inventare nuovi modi per riprendersi gli spazi, per ribadire il diritto alla presenza degli indesiderabili. Alla inquadratura, difesa, controllo, irrigidimento dello spazio pubblico, rispondono le manifestazioni di strada nomadiche che attraversano uno spazio senza volerlo possedere. Con una formula classica si potrebbe dire: esse insistono sul diritto di tutti di farne uso.
E di farne un uso che non sia quello disciplinato o consumista del conformismo dominante e soffocante.
Ne è segno anche il fatto che le proteste vivono oggi nelle piazze: Piazza Taksim, Liberty Plaza, Puerta del Sol, Place de la République… Non mirano più alla fabbrica o all’università, ma hanno nel carattere qualunque delle vie cittadine il segno distintivo del loro anonimato e del loro poter essere dovunque, senza rispettare le geometrie urbanistiche del potere. La piazza rappresenta il luogo di intersezione e di incontro di forme di vita diverse, che recupera l’idea di agorà che era stata alla base dell’antica democrazia greca. Nella piazza la vita dice che qualcosa deve cambiare, che la vita stessa può cambiare: i corpi che esprimono il loro dissenso esprimono l’utopia dell’altrimenti, senza rappresentarsi come sarà questo altrimenti. Basterebbe vivere senza violenza, senza razzismo, senza temere per la propria vita. A volte basterebbe anche solo poter respirare.
Questo fa delle rivolte del nostro tempo un panorama particolarmente frammentato che non si lascia ricondurre a un minimo comune denominatore. Però considerarle dei puri eventi staccati, senza alcuna correlazione tra loro, rischia di perdere di vista quanto c’è di comune nella loro sfida. Piuttosto bisognerà vederle come la costellazione dei sintomi di un’epoca interessata da violente trasformazioni e da rivendicazioni. Occorre un altro sguardo, che il libro chiama “uno sguardo notturno”, per cogliere il filo rosso che collega questi punti così differenti del pianeta che fanno di volta in volta l’esperienza di parlare lingue non troppo distanti le une dalle altre. Vediamo allora come tutte queste differenti forme di insorgenza – che spesso si richiamano al significante “democrazia”, come a un ideale completamente tradito o travisato dalle cosiddette “democrazie rappresentative” – nascono da un malessere planetario, da una forma diffusa di disagio che riguarda in maniere differenti tanto coloro che il cosiddetto “progresso” ha destinato a un ritardo incolmabile, quanto coloro che lo hanno conosciuto spesso solo nella forma delle ineguaglianze subite: “La rivolta esprime un malessere impreciso, manifesta un disagio vago ma assillante, rivela tutte le aspettative deluse. Lo sviluppo promesso, il progresso decantato hanno lasciato indietro un mondo dove si consente e si asseconda l’abisso dell’ineguaglianza, la logica del profitto, il saccheggio dell’avvenire, l’arroganza spettacolarizzata di pochi di fronte all’impotenza dei molti”.
È questo lo sguardo con cui la rivolta invita a vedere le relazioni politiche o le istituzioni statali “da fuori”, mostrando lo Stato non attraverso il suo auto-ritratto spettacolare, ammirato di sé, ma attraverso la prospettiva delle periferie, delle banlieues degli esclusi (come mostrava bene anche un altro libro italiano importante sulla rivolta, quello di Pierandrea Amato per i tipi di Cronopio). Essa rivela come il presunto carattere universale della rappresentazione politica non riguardi affatto tutti e come esso costituisca una dimensione abusiva, benché capace di auto-legittimarsi. Mostra anche come non tutti vogliano entrare dentro quella dimensione di rappresentazione e tuttavia non intendano essere liquidati da una sovranità che ha illecitamente esteso la propria giurisdizione ad aspetti della vita che nessun periodo storico precedente ha mai inteso normare. Restituisce così visibilità a forme altrimenti nascoste di controllo sempre più invasive. Così facendo compie un movimento che è quello della destituzione della sovranità. La rivolta è per vocazione destituente. (Così una delle riviste oggi più brillanti, l’italo-francese “K. Revue trans-européenne de philosophie et arts”, tutta dedicata al “potere destituente”, ha consacrato diversi dei suoi numeri su figure esemplari della rivolta come Antigone o Spartakus.)
Mi sembra che questo aspetto possa essere anche ricollegato a un altro dei libri di Donatella Di Cesare, quel Stranieri residenti che si occupava di tracciare le linee-guida di una filosofia delle vite migranti. Ci sono migrazioni che arrivano da lontano e che mostrano l’impotenza delle nostre frontiere a contenerne la spinta di chi non chiede altro che di poter vivere. Ma c’è anche un potenziale di trasformazione immanente alle nostre società, presente già nelle figure di coloro che abitano da sempre l’Europa e i suoi Stati per privilegio per nascita. È questa quella che il libro definisce “la rivolta anarchica” che è tale perché “mina al fondo l’arché, il principio e l’ordine dell’architettura politica… viola le frontiere statuali, denazionalizza i presunti cittadini, li svincola e li estranea, li rende provvisoriamente apolidi, li invita a proclamarsi stranieri residenti”, facendo di ciascun rivoltoso un “transfuga in senso extra-morale” che, abbandonando il luogo che gli è stato assegnato per privilegio di nascita, “sospende l’iscrizione nazionale si dis-identifica e si dis-implica, mette in questione l’appartenenza”. È questa la trasformazione che la rivolta chiama, è questa la potenza con cui le vite si riconoscono, affrancandosi dalle loro stesse paure e destinandosi a un altro abitare dello spazio pubblico.









